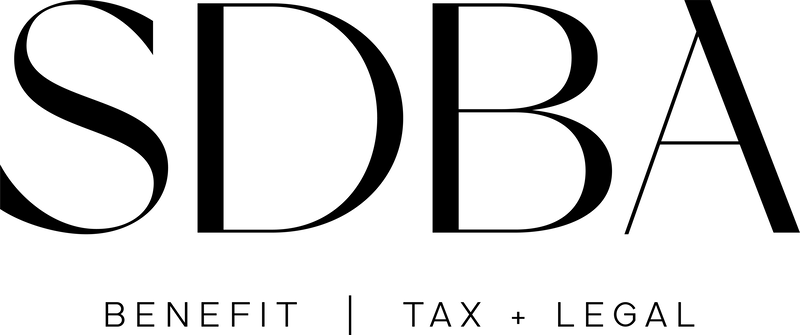Il delitto di false comunicazioni sociali (più comunemente noto come falso in bilancio) è previsto dall’art. 2621 c.c., che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Il bene giuridico tutelato dalla sopra richiamata norma incriminatrice è stato individuato dalla Cassazione a Sezioni Unite (n. 22474/2016) nella trasparenza societaria: con la previsione del reato in parola, in altri termini, si mira ad impedire che le comunicazioni sociali siano redatte con modalità decettive, ossia con modalità che impediscono ai loro destinatari di avere contezza dell’effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui versa la società.
Sono diverse le condotte che possono integrare il delitto di falso in bilancio, il quale può conseguentemente assumere diverse fattezze.
Viene innanzitutto in rilievo il falso in bilancio oggettivo, che ricorre quando nella comunicazione sociale sono riportati fatti materiali non corrispondenti al vero: si pensi all’omissione di voci di costo o all’esposizione di ricavi inesistenti o gonfiati.
Vi è poi il falso in bilancio valutativo: in questo caso la falsità non attiene al dato riportato nella comunicazione, ma alla valutazione che a tale dato viene attribuita. Ciò può avvenire con riferimento, per esempio, alle stime immobiliari e di magazzino o alle valutazioni di marchi, brevetti e know-how.
Vi è, infine, il falso in bilancio qualitativo, che attiene al modo in cui sono catalogate le voci di bilancio. Tale ipotesi ricorre frequentemente quando, al fine di mascherare l’utilizzo di fondi in modo illecito (per esempio nell’ambito di fenomeni corruttivi), la relativa spesa viene catalogata come se fosse lecita. Sul punto, v’è da rilevare come tale ipotesi di falso in bilancio sia quella che, anche agli occhi della giurisprudenza, ha assunto la maggiore rilevanza dal punto di vista sistematico, tanto che le Sezioni Unite (n. 22474/2016) hanno affermato che il delitto in parola è «un “reato spia” di fenomeni corruttivi, in quanto, ad esempio, attraverso l’appostazione contabile di false fatturazioni vengono costituiti i cosiddetti fondi neri utilizzabili per il pagamento di tangenti o per la consumazione di altre attività illecite».
Venendo ora ad analizzare gli elementi costitutivi del reato che ci occupa, va innanzitutto segnalato che trattasi di reato proprio: esso, infatti, può essere commesso unicamente da chi riveste le qualifiche soggettive indicate dalla norma incriminatrice, ossia dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori.
Tali soggetti – che non a caso sono coloro ai quali la legge civile attribuisce precisi doveri in tema di redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali – devono essere animati dalla finalità di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto: è pertanto necessario il dolo specifico.
Sempre restando in tema di elemento soggettivo, grande rilevanza assume l’avverbio «consapevolmente» impiegato dall’art. 2621 c.c. Tale norma, come si è visto, richiede che le condotte materiali sopra descritte siano tenute, appunto, «consapevolmente». Ciò esclude la rilevanza, ai fini dell’integrazione del delitto in parola, del dolo eventuale, nel senso che le condotte descritte dalla norma incriminatrice non costituiscono reato se il loro autore non ha perseguito la realizzazione del fatto, ma si è limitato ad accettare il rischio della sua verificazione pur di conseguire il vantaggio che si era ripromesso. In altri termini, l’art. 2621 c.c. richiede, in capo all’agente, il dolo intenzionale o, quantomeno, il dolo diretto: il primo ricorre quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto (ossia è animato dalla specifica finalità di fornire una distorta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società), mentre il secondo ricorre quando la realizzazione del fatto, pur non costituendo il fine ultimo perseguito dall’agente, è cionondimeno da quest’ultimo ritenuta certa o probabile al limite della certezza.
Al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice, nel 2015 il legislatore ha introdotto l’art. 2621-bis c.c., che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (anziché da uno a cinque anni) qualora il fatto sia di lieve entità. Tale norma detta anche i parametri che il giudice deve considerare al fine di ritenere la lieve entità del fatto: trattasi della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta.
Qualora il fatto sia talmente lieve da non raggiungere la soglia della penale rilevanza ai sensi dell’art. 131-bis c.p. (norma che prevede l’esclusione della punibilità dei fatti particolarmente tenui), l’art. 2621-ter c.c. subordina la pronuncia di una decisione assolutoria alla condizione che il giudice abbia previamente valutato, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori. Ciò impedisce di ritenere particolarmente tenui quelle condotte che, pur non essendo altamente insidiose per le loro concrete modalità o per le ridotte dimensioni del contesto societario in cui si sono estrinsecate, abbiano cionondimeno cagionato un significativo danno alla società stessa, ai soci o ai creditori.